Teorie della cancerogenesi e segni di malignità
Traduzione automatica
L'articolo originale è scritto in lingua RU (link per leggerlo) .
Negli ultimi anni si registra un costante aumento dell'incidenza di tumori maligni. Anche i dentisti si trovano a dover assistere pazienti oncologici, perciò è importante che possiedano un alto livello di conoscenze sulla prevenzione, diagnosi e trattamento dei tumori maligni. Il problema delle malattie oncologiche dell'area maxillo-facciale è legato all'incessante aumento dell'incidenza e della mortalità dei pazienti, e alla conoscenza non sempre completa da parte degli specialisti dei sintomi clinici dei tumori maligni e delle strategie di trattamento.
Per ulteriori informazioni attuali sulle varie malattie dell'area maxillo-facciale, visita la sezione Formazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.
Teorie della cancerogenesi
La cancerogenesi è un complesso meccanismo patofisiologico che porta alla formazione e allo sviluppo di un tumore. Esistono diverse teorie sulla cancerogenesi, ma la principale e più accettata è la teoria mutazionale. Si identificano due fattori chiave che contribuiscono allo sviluppo del cancro:
- trauma costante, irritazione;
- esposizione a sostanze specifiche chiamate cancerogeni.

Figura 1. Vigilanza oncologica.
A loro volta, i cancerogeni, dei quali oggi si conoscono numerosi, possono essere divisi in due grandi gruppi:
- cancerogeni esogeni – sostanze presenti nell'ambiente esterno, tra cui: coloranti anilinici, idrocarburi policiclici, benzopireni, fenantreni, composti aminoazoici, composti aromatici, amianto;
- cancerogeni endogeni – sostanze normalmente presenti nel corpo umano e che svolgono una funzione utile, ma che in presenza di certi cambiamenti possono provocare lo sviluppo del cancro.
Ai cancerogeni endogeni appartengono: ormoni steroidei, vitamina D, colesterolo, prodotti del metabolismo del triptofano.
Le neoplasie sono malattie polietiologiche, non esiste un unico fattore chiave che causa lo sviluppo del tumore. Questo processo è determinato da una combinazione di diversi fattori e condizioni, con un ruolo importante giocato dalla predisposizione genetica.
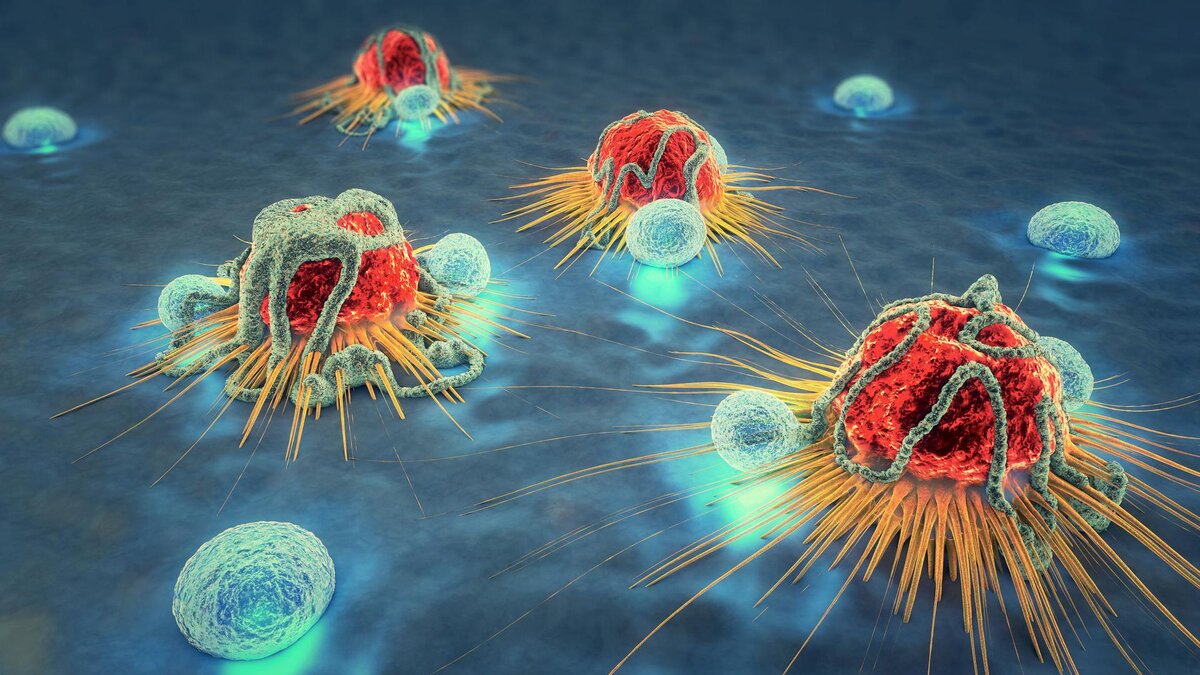
Figura 2. Cellule cancerogene.
Alla base della teoria mutazionale della cancerogenesi c'è l'idea che il cancro nel corpo sia il risultato dell'accumulo di mutazioni in singoli frammenti del DNA cellulare, che portano alla formazione di proteine difettose. Theodor Boveri, biologo tedesco, è considerato il fondatore della teoria mutazionale. Tutta la varietà di opinioni riguardo l'eziologia del cancro si riduce a quattro teorie chiave.
Teoria viro-genetica
Il ruolo principale nello sviluppo delle neoplasie appartiene ai virus oncogeni. Il processo di cancerogenesi, secondo questa teoria, subisce due fasi, in cui il ruolo del virus è diverso. Durante la prima fase, i virus colpiscono il genoma cellulare, trasformando le cellule sane in cellule tumorali, mentre nella seconda fase le cellule tumorali formate si riproducono, qui il ruolo del virus è assente.
Circa il 20% dei virus noti contribuisce allo sviluppo di varie forme di neoplasie negli animali sperimentali in condizioni di laboratorio. È stata dimostrata la possibilità di trasmissione dei virus cancerogeni tramite il latte.
Teoria fisico-chimica
Alla fine del 19° secolo esisteva la teoria dell'irritazione, che spiegava l'eziologia dell'insorgenza del cancro. La teoria fisico-chimica rappresenta un ulteriore sviluppo della teoria dell'irritazione con una serie di modifiche e aggiunte. Esistono diversi tumori maligni che sono considerati malattie professionali:
- cancro della pelle sulle mani dei lavoratori nei reparti di radiologia,
- cancro del polmone causato dalla polvere nei lavoratori delle miniere di cobalto,
- cancro del polmone in persone che fumano costantemente e a lungo,
- cancro della vescica urinaria tipico dei pazienti in costante contatto con coloranti anilinici.

Figura 3. L'apparizione di una mutazione.
Esistono prove dell'influenza degli isotopi radioattivi sulla formazione di tumori. Lo sviluppo del cancro è causato dall'esposizione a cancerogeni.
Teoria disontogenetica
Presuppone che la fonte di tumori maligni siano spostamenti embrionali cellulari-tissutali, patologie dello sviluppo dei tessuti, causate dall'impatto di fattori provocatori.
Teoria polietiologica
Alla sua base vi è una combinazione di vari fattori (virali, parassitari, chimici, fisici, disormonali), capaci di causare un grave disturbo metabolico. La formazione di una cellula tumorale è causata dall'influenza di vari fattori a seguito di una mutazione - trasformazione del genoma, il cui risultato è la formazione di un clone di cellule cancerose.
Caratteristiche dei tumori maligni
La malignizzazione è la fase finale della crescita del tumore, caratterizzata da manifestazioni visibili, un altro nome è la fase di malignizzazione. Esaminiamo i segni comuni di malignizzazione:
- La cellula acquisisce la capacità di dividersi e riprodursi in modo incontrollabile e sfrenato.
- Atipia delle cellule: le cellule tumorali differiscono nell'aspetto esterno dalle cellule del tessuto in cui il tumore ha avuto origine. Quando la neoplasia cresce rapidamente in dimensioni, è prevalentemente composta da cellule non specializzate (in caso di crescita eccessivamente rapida non è possibile determinare il tessuto che è la fonte della crescita del tumore). Con una crescita lenta, le cellule del tessuto mantengono caratteristiche simili a quelle normali e continuano parzialmente a svolgere le loro funzioni precedenti.
- Sullo sfondo della divisione incontrollata si osserva una patologia della differenziazione, la cellula rimane giovane e immatura (questa proprietà è l'anaplasia).
- Indipendenza, o autonomia, dall'organismo, dagli stimoli che controllano e regolano i processi vitali. Più rapida è la crescita del tumore, minore è la differenziazione delle cellule e più marcata è l'autonomia della neoplasia.
- In caso di tumore benigno non vi è alterazione della proliferazione e della differenziazione, durante la crescita di questo tumore aumenta il numero di cellule, di conseguenza i tessuti circostanti vengono spostati o compressi. In caso di tumore maligno si osserva una crescita infiltrativa, quando le cellule invadono i tessuti circostanti, distruggendoli.
- Metastasi. Le metastasi sono frammenti del tumore, cellule capaci di diffondersi attraverso la linfa o il sangue in tutto l'organismo, formando nuovi focolai tumorali. La metastatizzazione è un segno tipico della malignità del tumore.
- Impatto negativo del tessuto tumorale sull'organismo del paziente: intossicazione causata dai prodotti del metabolismo della neoplasia, dalla decomposizione del tumore. Il focolaio tumorale priva l'organismo della maggior parte dei substrati energetici, nutrienti, componenti plastici. Tutti i fattori sopra menzionati insieme rappresentano la cachessia cancerosa (esaurimento delle risorse vitali). Il processo tumorale è caratterizzato dai seguenti segni: proliferazione patologica, patologia della differenziazione delle cellule, tipiche di atipismo funzionale, biochimico e morfologico.
- La varietà di cellule nel focolaio tumorale è una proprietà di polimorfismo, un'altra caratteristica del processo maligno.
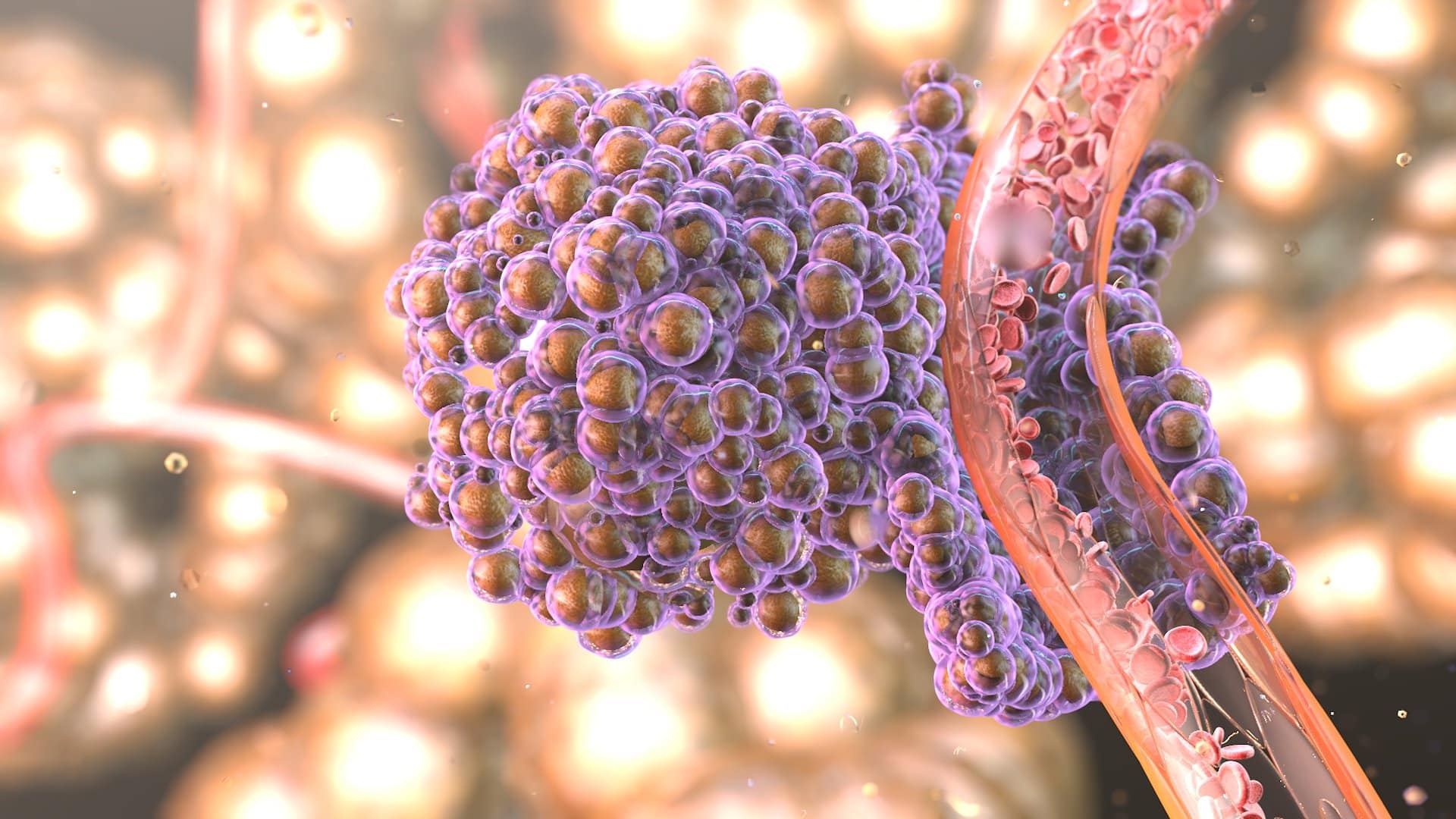
Figura 4. Metastasi.
Processi che contribuiscono alla formazione del focolaio tumorale
Normalmente, la mucosa orale è composta da tre strati: epitelio, lamina propria della mucosa e base sottomucosa. Le strutture fibrose della membrana basale separano lo strato epiteliale dalla lamina propria della mucosa, che vicino all'epitelio contiene numerosi papille che si insinuano nell'epitelio. Senza un confine netto, la lamina propria passa alla base sottomucosa, che è costituita da tessuto connettivo lasso dove si trovano piccoli vasi e ghiandole salivari. Più è pronunciata la base sottomucosa, maggiore è il grado di mobilità di quella sezione della mucosa orale.
I disturbi esudativi e alterativi sono tipici per il processo infiammatorio acuto, proliferativi per quello cronico. I cambiamenti descritti favoriscono il disturbo della cheratinizzazione, che innesca i meccanismi di trasformazione tumorale. Da qui l'importanza di identificare i processi che influenzano la formazione del cancro.
Acanthosis - proliferazione di cellule spinose e basali, che porta all'ispessimento dello strato epiteliale, manifestato dall'apparizione di lichenificazione e noduli.
Paracheratosi - una patologia della cheratinizzazione con la comparsa di focolai di vegetazione, lichenificazione, noduli. Microscopicamente si determina la perdita totale o parziale nello strato granuloso dell'epidermide a causa di un disturbo nella maturazione del cheratoialina e dell'eleidina. La cheratina appiccicosa scompare dallo strato corneo, risultando in una desquamazione dell'epidermide in cui le squame sono facilmente rimovibili.

Figura 5. Desquamazione del bordo rosso delle labbra.
Discheratosi - un disturbo della cheratinizzazione di alcune cellule dell'epitelio. La discheratosi maligna si osserva nel carcinoma a cellule squamose, nella malattia di Bowen. Ipercheratosi - un processo in cui lo strato epiteliale corneo si ispessisce eccessivamente a causa della formazione intensiva di cheratina.
Informazioni sempre aggiornate su vari settori dell'odontoiatria possono essere trovate sul sito.
